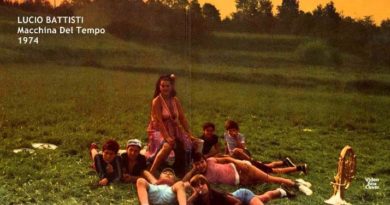La fatica tra etica e illusione
Sono albe strane quelle di inizio Ottocento. Un uomo si leva alle sei di un febbraio troppo freddo nel mentre altri si ritirano esausti dal gioco, portati in carrozze chiuse, a sancire la separazione tra una vita e un’altra, in un lampo visivo. Prende una bacinella di ferro l’uomo delle sei, versa acqua gelata da una brocca, congiunge le mani e le tuffa nel recipiente. Si struscia la faccia, con gli occhi ancora gonfi si sfila la camicia da notte. Non c’è servo che gli porti il pettine o il panciotto, si avverte un fanciullo tossire in un letto in fondo alla stanza. Una donna scalza gira per la casa, rompe un pezzo di pane e col cucchiaio raschia il fondo di un barattolo di marmellata. Addossa tutto in un piatto di legno e lo poggia su un mobile, dando una carezza all’uomo che si veste.
La liturgia della fatica ha questi sapori e questi spazi, lo squillo di tromba è l’acqua tenuta ferma tutta la notte, il segno della croce è l’imposta della finestra che sputa dentro un chiarore smorto, livido. La preghiera è null’altro che il libro contabile aperto come breviario, le parabole sono gli scudi da avere indietro, i farisei gli speziali e, la Trinità da benedire, assume le fattezze del mercante ritratto a stampa sopra la spalliera del letto:pazienza, piacere della fatica, guadagno.
Non fu sempre cosi’, non sarà sempre cosi’. L’uomo cambia, ma noi non ci crediamo, e i paesaggi mentali ereditati li convertiamo in un lascito perenne, aderendovi sconfinatamente. L’uomo del febbraio di inizio Ottocento non era l’uomo di sempre, fu invece una transizione, un nunzio di una storia a cui prestammo ascolto per due secoli circa per poi, lentamente, in un eccesso di rabbia e delusione, votarci ad altri profeti. Il passaggio è solo all’inizio, e come accade in ogni momento di tensione tra due mondi, il vecchio che si sente minacciato cerca di serrare le fila e rincarare la dose. Risultato? I Carrefour aperti 24 ore.
La mitologia del lavoro è una questione per alcuni versi religiosa, cristiana soprattutto. Vi risparmio le analisi di Weber sul protestantesimo e la nascita del capitalismo moderno, ma una considerazione va fatta: applicare lo statuto di salvato all’uomo di successo ha prima esaltato il lavoro e poi, col tempo, corrotto, essendo prevalso il vizio sempiterno dell’essere di svuotare l’iniziale ideale a favore della sua unica risultanza pratica. L’ideale è sempre stato un pretesto per agire con giustificazione presunta nella vita attiva, una sorta di patente di legittimità, di superiorità morale dell’agire. L’ideale carica il pratico di un qualche soffio spirituale, lo informa di una specie di religiosità. E si sa, gli uomini sono avvinti e trasfigurati dalla luce confusa del trascendente.
C’è stato un tempo, un lungo tempo, iniziato alle sei di quel mattino di febbraio, in cui gran parte dell’umanità cosiddetta “evoluta” si è schierata a fianco di una categoria da sempre respinta, da sempre riservata ai dannati, ai sommersi: la fatica. Una fatica che diventava piacere, abito di dignità, traccia e prova della superiorità del nuovo uomo rispetto al vecchio. La fatica cominciò a significare applicazione, dedizione profonda alle cose, volontà di non restare sul pelo dell’acqua per poi buttarsi giù, a vedere l’abisso che inzio aveva e se c’era in esso una fine possibile. La fatica significava replicare il gesto, ritornare più volte nella galleria come il minatore, e liberare la montagna, ad ogni nuova discesa, da un pezzo. Gli antiquari, i collezionisti aristocratici avevano il profilo di questo uomo nascente, ma non vollero badarci. La fatica dal lavoro si è riversata nello studio, e da allora innumerevoli intellettuali hanno sceso i cunicoli del sapere in cerca di un dato, di un indizio che potesse far risplendere di nuovo senso la teoria azzardata.
La fatica significava lentezza, perseveranza, voleva dire ascoltare venti volte la Traviata fino al momento della comprensione piena. Era azzuffarsi in mischia su un pezzo del sapere dimenticando il resto del mondo, era specializzarsi, atomizzarsi, dare il benservito a quell’uomo enciclopedico che, come sosteneva D’Alembert, saprà risolvere un problema di matematica e leggere un poema, votarsi ai problemi sociali e divertirsi a teatro. Era un mondo, quello anteriore all’uomo delle sei, ancora in qualche modo organico, tenuto da fili non troppo sottili, da ganci fermi su cui ci si poteva attaccare e scendere con una carrucola, senza il rischio di vedersi precipitare. Scopo delle esistenze non fu più sapere quante più cose possibili, bensì sapere anche un piccolissimo frammento che un altro non sa. La borghesia dell’intelletto dava così inizio a un nuovo esclusivismo, pericoloso, cattivo: ciascuna provincia finì per credersi un impero.
Sono mattini strani questi del 2017. Un uomo si è svegliato alle dieci, e si è tirato le coperte fino agli occhi, vuole dormire un altro po’. La fatica lo stanca al solo pensiero. Gli hanno commissionato una ricerca, non scenderà scale. Nessuna biblioteca, si affiderà al gesto del rabdomante, muoverà l’indice su tasti, si troverà a fare i conti con un documento evanescente, con una prestazione al silicio. Il lavoro lo stritola. Sogna mari o semplicemente domeniche che poi non sa riempire, ormai disabituato a cercare. Il senso lo trova nel rifiuto. Nega senza affermare. Gli ultimi ordini del vecchio mondo lo obbligano a sfiancarsi come un dannato martoriato dalle punture nell’antinferno. Vuole essere lasciato in pace. Più nessuna fede. Stanotte ha sognato l’uomo delle sei, un brivido lo ha scosso. Ha febbre ora. Rinuncia anche al compito. Si mette a dormire.